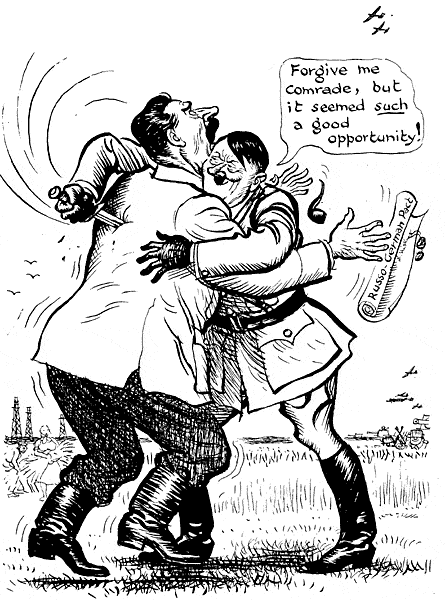Totalitarismi uguali e contrari
La recente decisione, in sede europea, di equiparare i simboli ideologici del nazismo e del comunismo come simboli d’odio (cosa peraltro già vista nel 2019 sul piano delle ideologie), in modo da rafforzare il contrasto alla propaganda putiniana e, pertanto, da vietare per l’esposizione in pubblico, ha riportato in auge il problema fondamentale del dibattito sui totalitarismi novecenteschi. Personalmente, tratto spesso e volentieri il tema dei tre totalitarismi, sia nel mio corso su Educazione cittadinanza e patrimonio culturale, sia nei corsi/moduli di Pedagogia generale e sociale; oltre a essere indubbiamente intrigante, specie per studenti e studentesse più “impegnati”, è fondamentale per comprendere la natura di rapporti politici e culturali che ritornano a farsi sentire nelle questioni della cittadinanza, dell’inclusione, dell’accoglienza, dell’idea di società da costruire, anche e soprattutto attraverso l’educazione, sia per impostazione scolastica, che per la relazione narrativa e ideologica con il patrimonio culturale e l’identità nazionale.
Per passione politica personale, oltre che per correttezza intellettuale, ho letto diversi testi storici e storiografici di vario orientamento, sull’URSS di Stalin, sulla Germania di Hitler e, ovviamente, sul fascismo creato dal decano di tutti i dittatori europei, Mussolini. Tra i molti che potrei consigliare, dato il tema della comparazione, segnalo due testi collettanei dal medesimo titolo: Stalinismo e nazismo. Dittature a confronto, a cura di I. Kershaw e M. Lewin, per Editori Riuniti; e Stalinismo e nazismo. Storia e memoria comparate, a cura di H. Russo, per Bollati Boringhieri. Si tratta di atti di convegni ad alto livello, che raccolgono contributi di molti studiosi e ricercatori internazionali, i quali vanno a fondo di molte questioni e forniscono un esempio di storiografia rigorosa, lontana da faziosità inutili (in fondo lascio qualche altro consiglio di lettura).
La questione non è certo nuova, tanto che ho deciso di recuperare un brano da un mio vecchio blog, risalente a una ventina d’anni fa, quando mi ritrovai impegnato in un interessante dibattito con un ragazzo di idee liberali. Intelligente, ma con una tendenza neocon ad accomunare le altre ideologie nel calderone del totalitarismo (una categoria inventata – e ormai abusata – proprio dai liberali, a fronte di una esaltazione del modello democratico innestato sull’economia capitalista). Una sua affermazione, in particolare, mi fece prodigare in una lunga risposta. L’affermazione [riportata in basso nel riquadro giallo], posta in maniera interrogativa, riguardava l’essenza del dibattito: nazismo e comunismo sono forse la stessa cosa? Hitler e Stalin erano le due facce di una stessa medaglia? Io, naturalmente, non lo credo. Penso sia una comparazione superficiale e faziosa, che non tiene conto delle differenze tra gli ideali, ma solo delle similitudini tra le esperienze storiche di regime. Un parallelismo si può fare tra forme di governo, controllo, repressione ed organizzazione sociale, nonché culto delle personalità; ma non sul piano delle idee, totalmente opposte le une alle altre nelle prospettive, nei valori e nella concezione del mondo sociale. Accostare comunismo e nazismo, considerarli uguali nei contenuti per i risultati storici delle loro applicazioni, è una tendenza omologatrice del pensiero neoliberale attuale, che io rifiuto.
Oggi, a distanza di così tanto tempo, risponderei più o meno le stesse cose, specificando meglio alcuni punti su cui temo di essere stato impreciso, come mi pare di evincere dal testo che seguirà. Per esempio, sulla figura del proletario nel “mondo migliore”: se si tralascia la propaganda, in una compiuta società comunista essa non esisterebbe più, scomparendo assieme alla distinzione tra classi sociali. O sulla natura dell’ideologia: per Marx era sì falsa coscienza, ma bisogna tenere in conto anche Gramsci, per il quale l’ideologia è una costruzione di classe, cioè un complesso di idee e di valori che giustificano e indirizzano l’azione delle classi, alimentandone l’egemonia, o la lotta per la sua conquista. O, ancora, sulla causa primigenea della chiusura dittatoriale dell’URSS, che ai tempi attribuivo quasi del tutto all’accerchiamento del paese dopo la rivoluzione bolscevica; oggi so essersi sviluppata per questioni molto più complesse, tanto esterne (le armate di Kolciak e Vrangel, i contingenti stranieri ecc.) quanto interne (come la lotta per la successione a Lenin, lo scontro Trotsky-Stalin, le Opposizioni interne di destra e di sinistra ecc.). Sottolineando, ancora una volta, che il mio riferimento principale è alle ideologie in quanto tali, solo secondariamente agli aspetti dittatoriali dei regimi concreti.
In ogni caso, ancora dopo vent’anni quella risposta conserva elementi abbastanza validi, che mi sento di poter riproporre con qualche aggiustamento.
Domanda – “Nazismo e comunismo predicavano un mondo migliore (quello ariano o quello proletario), prevedevano un rito di sangue propiziatorio (la dittatura del proletario, l’eliminazione delle razze inferiori), si vedevano come un antidoto alla decadenza morale e sociale del mondo capitalista borghese. Entrambi si concretizzarono in forme di Stato totalitarie, basate sul terrore e la propaganda, la polizia segreta, la guerra infinita contro il nemico (interno ed esterno), la superiorita’ morale e storica del proprio modello. Insomma ideologie diverse ma realizzazioni pratiche pericolosamente vicine. Parole diverse per gli stessi concetti?”
Risposta – No, assolutamente. Sul piano delle idee, nazismo e comunismo sono quanto di più antitetico ci possa essere, e non possono essere accomunati in alcun modo.
L’idea di un “mondo migliore” è un concetto in sé vago, ma tra il “mondo migliore” dei nazisti e quello dei comunisti c’è una differenza abissale: da un lato abbiamo il dominio assoluto di una presunta “razza” superiore, unica depositaria di poteri e privilegi, in un’organizzazione sociale rigidamente gerarchizzata, in cui discriminazione, diseguaglianza ed emarginazione sono parte integrante della vita in comune. Dall’altro, abbiamo una società di eguali, ognuno con i suoi diritti e le sue garanzie, senza distinzioni di alcun tipo nell’organizzazione sociale, in cui ognuno è libero di autodeterminarsi e di decidere della propria vita, senza assogettarsi al potere economico (il capitale) o al potere politico (data l’idea di estinzione dello Stato), e in cui valori come la solidarietà e la fratellanza siano alla base dei rapporti sociali (cosa che i nazisti aborrivano, per lo meno al di fuori della loro “razza”). Visioni agli antipodi quindi, già a partire dai soggetti: l’ariano sarebbe un essere supernaturale, che ha virtù particolari in merito alla sua costituzione genetica (con mito del sangue e altri concetti riadattati da antiche credenze); il proletario è un membro della società borghese che rivendica i suoi diritti e una giustizia sociale che il capitalismo non sa offrire. Due soggetti molto diversi, direi.
L’espressione “rito di sangue propiziatorio” è quanto mai forzata, nel caso del comunismo, in quanto la dittatura del proletariato non va certo intesa come sterminio della classe borghese. Non c’è alcuna possibilità di avvicinare anche solo lontanamente lo sterminio nazista all’idea di dittatura del proletariato, perché questa espressione – certamente ambigua e spesso fraintesa – sta ad indicare non una dittatura come quella sovietica (dominio del partito sullo Stato e la società civile), bensì il dominio dei valori di una classe su quelli di un’altra. Non uno stato totalitario comunista, ma una predominanza delle istanze di giustizia ed eguaglianza sociale, di rifiuto dei valori borghesi fondati sui rapporti economici diseguali. Il comunismo, come il socialismo, è l’elaborazione moderna del “sospiro delle anime oppresse” che nei secoli hanno cercato una rivalsa contro gli sfruttatori, e che nel corso della storia è passato, questo “sospiro”, dalle rivolte degli schiavi al cristianesimo, al liberalismo borghese e al socialismo filosofico e politico. E infatti, Marx ed Engels riconoscono pienamente i meriti storici della borghesia nel Manifesto del Partito Comunista, ma ne criticano l’evoluzione successiva all’abbattimento dell’Ancien Régime, per la disuguaglianza sostanziale che invalida l’uguaglianza formale.
Il nazismo è invece una degenerazione della parte più retriva e reazionaria del conservatorismo, un’ideologia nel pieno senso del termine (che per Marx era falsa coscienza, e il comunismo è diventato ideologia proprio con Stalin e il dominio sovietico sul movimento comunista internazionale), in cui tutto è basato sulla violenza e sull’odio per il diverso, sulla difesa strenua dei privilegi razziali, sulla discriminazione e il dominio assoluto, sull’esclusione e l’eliminazione di ogni elemento di disturbo e di ogni peso per la società comunitaria. A tutto questo si aggiunge un fanatismo mistico che alimenta l’idea della “missione divina” di purificazione del mondo dal Male, quindi lo sterminio delle “razze” inferiori, il lager come produzione industriale di morte, erano già presente nelle idee stesse, laddove nell’ideale comunista non erano affatto concepiti il Gulag o le altre forme di repressione politica adottate dai regimi del socialismo reale.
Ed è proprio questo il punto fondamentale: nel comunismo esiste una dicotomia tra la teoria e la pratica, mentre nel nazismo, come nel fascismo (al netto della sua natura “camaleontica” sottolineata a suo tempo da Togliatti), teoria e pratica sono identiche, sono conseguenti. Dunque come è potuto succedere che un ideale di libertà, uguaglianza e fratellanza come il socialismo/comunismo abbia generato il Gulag? Qui bisogna guardare alle contingenze storiche: le democrazie occidentali hanno fatto con la Rivoluzione russa ciò che le monarchie fecero con la Francia rivoluzionaria, ossia hanno assediato il paese ribelle e ne hanno soffocato lo sviluppo economico, politico e sociale. Questo è il modo giusto per stroncare qualsiasi rivoluzione, costringerla a chiudersi in sé stessa. Infatti, in Francia l’evoluzione storica ha portato da Babeuf a Napoleone, dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo ai cannoni dell’impero. In Russia, il fermento rivoluzionario si è scontrato con l’accerchiamento del Paese, con l’ostilità delle potenze straniere coalizzate contro il “pericolo rosso”, e di fronte a questo non ha potuto far altro che blindarsi, finendo con l’involversi in una dittatura che Stalin rese sempre più repressiva e burocratica. E con uno come Stalin, il paese avrà anche potuto resistere e consolidarsi, ma non ebbe più occasione di evolversi, nemmeno con la “destalinizzazione”. L’assedio ha provocato naturalmente la crescita della paranoia nello Stato e nel popolo, così si sono sviluppate le forme repressive sempre più spietate che hanno portato agli orrori del Gulag. E questo, in forme non dissimili e per molti motivi di carattere storico-politico, è accaduto per l’Unione Sovietica come per gli altri regimi autodichiaratisi comunisti.
Pensiamo all’Occidente liberale, democratico e cristiano, anch’esso convinto, oggi più che mai, della superiorità morale del proprio modello: nel corso dei secoli è passato per il colonialismo, lo schiavismo, l’oscurantismo religioso, lo sfruttamento dei paesi del Terzo Mondo. Persino nella decolonizzazione ha impedito che quelle nazioni potessero autodeterminarsi, fissando confini che costringono tutt’ora etnie diverse a convivere forzatamente; foraggiando governi deboli e pronti a collaborare economicamente a vantaggio degli ex-colonizzatori; sfruttando non solo risorse naturali, ma persino le antiche, dannate rivalità tribali per il proprio mercato delle armi (penso a molte situazioni nei paesi dell’Africa). Non ha avuto remore, il Primo Mondo, a sostenere dittature militari sanguinarie in America latina per impedire l’avvento di governi socialisti (a iniziare da Allende). Stesso discorso potremmo fare più in generale per la Chiesa, nel corso della storia, dalla Santa Inquisizione alle conversioni forzate dei popoli indigeni nelle americhe e in altri luoghi. Sfruttamento, violenza, umiliazione, repressione: queste cose le abbiamo fatte e le facciamo ancor’oggi anche noi, subdolamente, sottilmente.
Ma, per dirla con Manacorda, cancelliamo Gesù per via dell’Inquisizione, o di papi come Pio XII? Cancelliamo il pensiero liberale, da Croce a Bobbio, per via dello schiavismo, del colonialismo e dell’attuale sfruttamento del Terzo Mondo? Oppure tracciamo una linea di confine tra le idee e la pratica storica? Nel caso del comunismo, cancelliamo Marx a causa di Breznev e Ceausescu, oppure vogliamo renderci conto che, forse, la colpa non risiede nelle idee, ma nelle persone, nei fatti e nei rapporti concreti della Storia, come succede per il liberalismo borghese, la religione cristiana e tutte le altre espressioni della nostra storia democratica?
Io sono per la seconda linea guida. Un conto è non condividere l’idea del comunismo, tutt’altro è essere anticomunisti, che vuol dire adottare un’altra ideologia basata unicamente sulla distruzione del Nemico; tutto per eliminare la spaventosa minaccia ai propri miseri interessi, laddove si confonda il benessere con la libertà. [circa 2007]
Qualche consiglio bibliografico (non esaustivo)
- Stalinismo e nazismo. Dittature a confronto, a cura di I. Kershaw e M. Lewin, Editori Riuniti
- Stalinismo e nazismo. Storia e memoria comparate, a cura di H. Russo, Bollati Boringhieri
- E. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza
- R. De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Laterza
- N. Merker, Il nazionalsocialismo. Storia di un’ideologia, Carocci
- R. A. Medvedev, Lo stalinismo. Origini, storia, conseguenze, Mondadori
- A. Salomoni, Lenin e la rivoluzione russa, Giunti
- L. Canfora, Critica della retorica democratica, Laterza
- M. A. Manacorda, Perché non possiamo non dirci comunisti, Editori Riuniti (l’edizione Scipioni, tascabile, ha un capitolo aggiuntivo sull’equiparazione tra nazismo e comunismo)
Segnalo anche l’opinione di M. Saudino e una conferenza del 2020 di A. Barbero.